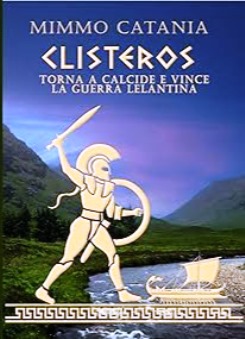Michele Ingenito
Il TAR di Milano ha condannato l’Università di Pavia a rimborsare ai propri studenti 70 euro a testa per eccesso di tasse. La condanna andrebbe estesa ad altri 33 atenei nazionali per analogo motivo. La notizia è clamorosa, non tanto per l’entità del rimborso individuale, quanto per la conferma di una tendenza esplosa una decina di anni fa nella gran parte delle nostre università. Quella, cioè, di ‘facilitare’ il percorso formativo, con automatico incremento del numero degli immatricolati. Allo stesso tempo, vista la degenerazione a macchia d’olio di quel fenomeno che ha ‘giustificato’ l’immissione in ruolo di migliaia di docenti grazie ai concorsi ‘locali’ (sinonimo elegante per truccabile/truccato), spesso senza la necessaria copertura di spesa, si è pensato da più parti di ‘limare’ per eccesso l’entità delle tasse a danno dei più deboli e indifesi. Morale? Studenti (e famiglie) penalizzate oltre il lecito, qualità e organizzazione dell’istruzione mai così bassa nel suo profilo scientifico, didattico e accademico, fallimento del binomio “Università-Occupazione” nello spirito autentico delle lauree triennali della ancora più fallita legge Zecchino del 2001. Dovendo ‘mantenersi’ da sole (o quasi), molte università italiane si sono lasciate soggiogare, infatti, da una asfissiante politica interna di tipo assai spesso clientelare, sterilizzando le risorse di uno stato eterno Pantalone, convinte che la pacchia sarebbe durata se non all’infinito, certamente a lungo. Tanto a lungo da consentire ai soliti capoccioni, rettori (in molte sedi quasi sempre gli stessi) assetati di poltrone e di potere, decisi a campare di rendita, vita (accademica) natural durante. Ci è toccato per almeno dieci anni (2001-2011) verificare in prima persona (il che ci rende testimoni non smentibili) l’onta di politiche ‘culturali’ (sic!) da far rabbrividire i più zotici tra gli stessi parassiti dello studio. Una università simbolicamente antica a dir poco quanto Ippocrate, che ha letteralmente regalato per decreto, a migliaia di studenti, esami definiti prove e riguardanti discipline di fondamentale importanza per il loro curriculum formativo,culturale e, soprattutto, oggi come oggi, professionale. Con una spudoratezza ed una arroganza che hanno imbarbarito il percorso di studio di dieci generazioni di studenti (una generazione per ciascun anno di immatricolazione, ovviamente), magari riconoscenti’ per tanta magnanimità, eppure incolpevoli di una inverosimile, indegna mediocrità gestionale per una università di questa repubblica associabile ad uno sperduto atollo delle banane. Non servono le denunce: controproducenti, inutili e paradossalmente contrarie a chi le propone. Solo quando, naturalmente, per garantirsi la indispensabile ‘protezione’, il prezzo da pagare per l’ineffabile principe del potere è l’immancabile messa in cattedra del ‘pezz’ è core’ di turno del solito asservito procuratore (per fortuna dei tempi andati), e di relativo sottoposto-gregario, asservito interprete delle ‘volontà in codice’ del capo, oltre che, a sua volta, beneficiario diretto di certe ‘logiche occupazionali’ del territorio. La corruzione morale, purtroppo, è indimostrabile quando esercitata da chi proprio quella corruzione deve combattere; e a nulla servono i tentativi pure ufficiali dei legittimisti di turno, quando essi, pericolosamente per loro, cozzano contro l’arroganza del potere e le sue oscure e pur presenti ragnatele, erosive di ogni azione di pulizia e di legalità. Sfornare sul mercato l’ignoranza certificata rappresenta uno dei maggiori crimini contro la società del nostro paese. Proprio perché investe il patrimonio forse più autentico e prezioso del progresso, dell’etica, della civiltà: la cultura. Se di simili fattacci fosse investito l’attuale Presidente della Repubblica sarebbero stati dolori per tutti. Ma Giorgio Napolitano, si sa, ha altre gatte da pelare e le malefatte di provincia restano dove sono. Certi responsabili supertogati di cultura accademica non sopravviverebbero un solo giorno in una pur media università greca, turca, slava o occidentale in genere che si rispetti. Se, specie nel nostro Mezzogiorno, le lauree brevi sono fallite, se la loro competitività internazionale è miseramente franata, se non sono state attese le esigenze del mercato, lo si deve proprio ad una generazione di personaggi che hanno capito poco o nulla del rapporto qualità formativa-lavoro; ma molto, moltissimo, degli affari, del clientelismo, della politicizzazione becera della cultura. Eppure, per quanto poco conciliabile sia la contraddizione derivante dalla esclusione delle università italiane dalle classifiche internazionali rispetto a molti dei suoi laureati considerati tra i più brillanti nei gruppi di ricerca stranieri, sono effettivamente eccessivi quegli elementi carenti che solo potrebbero favorire l’inserimento dei nostri atenei nei ranking internazionali. Tra questi, oggi come oggi, la non possibilità di accedere al credito per l’autofinanziamento degli studi, i mancati corsi di lezione (tutti) in lingua inglese, il distacco eccessivo con il mondo del lavoro, un’offerta esasperata incapace di rispondere alla domanda. Né le eccezioni, che pure esistono, riducono la negatività di un fenomeno che, nel suo complesso, investe la maggioranza degli atenei italiani, ahinoi del Sud soprattutto. Il fallimento delle lauree triennali non è dipeso tanto dalla bontà o meno di una proposta; quanto, invece, dalla incapacità di rendere professionalizzante il percorso di una formazione rapida di livello accademico. Per anni abbiamo assistito alla razzia delle discipline quadriennali da compattare a tutti i costi nei percorsi brevi o triennali. In poche parole, nessuno ha voluto rinunciare alla propria cattedra e al proprio insegnamento di titolarità. Con l’unico risultato di ammucchiarli in tre anni rispetto ai quattro o cinque anni in precedenza necessari. Con una quantità di studi teorici che ha dilaniato le risorse intellettive e spesso psicologiche dei diretti interessati – cioè, degli studenti, costretti ad inseguire sedute di esami a raffica, concentrate quasi tutte nella metà del tempo anticamente previsto. La calata delle brache è stata pressoché generale. Meglio tenersi cattedra e insegnamento, quindi, anche a costo di mollare la presa;facilitando, cioè, il superamento dell’esame per evitare ribellioni e proteste. E, nei casi per fortuna rarissimi di autentici delinquenti di vertice accademico maldisposti nei confronti dei colleghi intellettualmente onesti, l’accettazione del principio assurdo ed ingannevole dell’esame/prova riconosciuto d’ufficio ha rappresentato la più intollerabile, indecente ed inqualificabile forma di violenza ai giovani, alla civiltà, alla cultura, all’etica, alla legalità del nostro paese. Da più parti viene sottovalutata la diatriba sul valore legale del titolo di studio. Le università eccellenti si conoscono e, quindi, non vale la pena eliminare quel tipo di valore. Non ne siamo convinti. Ci sono ancora troppe frange del nostro territorio nazionale, specie meridionale, non in grado di valutare il significato di una laurea conseguita al Politecnico di Torino rispetto a quello di Laurificio. In definitiva, per ora, siamo dell’avviso che, negli ultimi anni, siano troppe le università costruite in Italia, università per ogni territorio. Bisognerebbe, invece, pensare (ad) una università che guardi il territorio, evitando di incrementare masse incontrollate di docenti non sempre utilizzabili proficuamente e che, peraltro, incidono pesantemente sui bilanci degli atenei. Con l’unico risultato di bucare il rapporto entrate-uscite degli atenei, nella prospettiva pressoché certa di un fallimento finanziario generale e conseguenti danni per tutti.