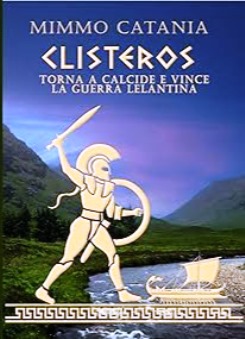Avv. Giovanni Falci
(penalista – cassazioni sta)
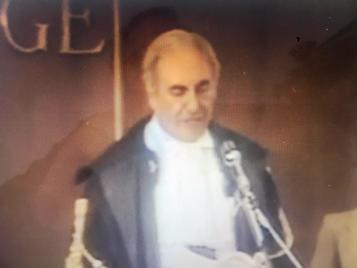
SALERNO – Depositai i motivi di appello nei quali dovetti contenere il mio disappunto e non fui diretto e chiaro come avrei voluto (avrei rischiato l’oltraggio); cercai di non farmi prendere la mano. Inoltre non avevo scritto del fatto che prove di P.A,2 erano state utilizzate per P.A.. Mi ero riservato il colpo di scena nella discussione.
A questo punto iniziò l’attesa della fissazione del dibattimento di appello che si sapeva, non poteva essere distante per non fare scattare le c.d. scarcerazioni automatiche per decorso del termine massimo di carcerazione.
Ed infatti, a giugno, eravamo di nuovo tutti nell’aula Ticino per celebrare il grado di appello del processo innanzi la V sezione della Corte d’ Appello di Napoli.
Quella mattina della prima udienza c’era la solita diatriba tra chi riteneva che fossimo stati “fortunati” di essere capitati con questa sezione e chi, invece si lamentava di questa assegnazione. Io non potevo esprimermi. Non avevo fatto molti processi a Napoli e, perciò non avevo avuto esperienze né negative né positive. Alberto Simeone era contento, e questo mi bastava per esserlo anche io.
In effetti, in genere, il metro di gradimento per gli avvocati di un determinato giudice è il seguente: se ci hai vinto una causa è un ottimo magistrato, equilibrato, un collegio che giudica con serenità; se ci hai perso, è un pazzo, uno che non sa assolvere, un colpevolista, un collegio da evitare.
E’ chiaro che sono giudizi direi, “interessati”, e come tali inattendibili.
Salutai un po’ tutti, chi per nome e chi chiamandolo “avvocato”; ci sono alcuni colleghi che, benché me lo abbiano chiesto di dargli del tu, non riesco proprio a farlo. Sarà una forma di esagerata riverenza.
Vidi che era presente in aula, sul banco che era stato del P.M. Marmo, il Procuratore Generale che mi dissero chiamarsi Armando Olivares.
Mi sembrò una brava persona, diciamo che mi piaceva più di Marmo, ma questo era abbastanza scontato. Quel P.G. per lo meno, a differenza di quel P.M., non sembrava così pieno di sé e non si dava molte arie, anzi era sorridente e cordiale, in maniera spontanea, con gli avvocati che gli stavano vicino e si intrattenevano a colloquiare.
Occupai un posto accanto Alberto Simeone e, mentre parlavamo del più e del meno, suonò la campanella che annunciava l’ingresso della Corte.
Entrarono i tre giudici e subito, a pelle come si suole dire, ebbi una impressione positiva del collegio. In particolare mi colpì il Presidente Antonio Rocco.
Aveva un sorriso disteso, autentico, che mi sembrava rassicurante.
Non aveva una faccia con lineamenti gentili, ma abbastanza marcati, ricordava, anche nell’altezza, vagamente l’attore Christopher Lee, il famoso interprete del Conte Dracula, però, ciò nonostante si capiva che era una persona tranquilla, per bene.
Era un po’ come mio padre che sembrava severo nell’aspetto, ma dentro era tenero, gentile.
Ci accolse con il sorriso ci invitò a sederci e diede inizio al dibattimento di appello con il solito appello degli imputati e dei difensori al quale risposi per due volte “presente” alzandomi per farmi vedere.
La causa come avviene in appello, ebbe inizio con la “relazione” del giudice relatore che può essere uno qualsiasi dei tre del collegio.

Il nostro giudice relatore era il dott. Michele Morello altra persona che subito mi ispirò fiducia, anch’egli disteso e tranquillo, espose con dovizia di particolari l’iter che aveva condotto alla sentenza, i punti cruciali della motivazione della stessa, le doglianze scritte nei motivi di appello, le richieste di rinnovazione formulate. Non tralasciò niente e, soprattutto, non tralasciò nessun imputato, furono tutti individuati con nome e cognome.
In appello sparirono subito “gli altri” del primo grado.
Il terzo giudice del collegio era il dott. Carmine Ricci che, vuoi perché in compagnia di due “simpatici”, vuoi perché di aspetto distinto e aristocratico, andava bene anche lui, per lo meno a livello empatico.
Finita la relazione bisognava subito, in via preliminare, pronunciarsi sulle richieste di “parziale rinnovazione del dibattimento”, cioè bisognava stabilire se le richieste di prove avanzate dagli appellanti, dovessero o meno trovare ingresso in questa fase del giudizio; va da sé che avrebbero trovato ingresso se la Corte le avesse ritenute, non ricordo all’epoca se si dicesse, utili o indispensabili alla decisione.
Il P.G. Olivares, bassino e senza capelli, si oppose fermamente alle numerose prove richieste soprattutto da Enzo Tortora; per quanto riguardava la mia rinnovazione non si oppose perché in effetti si trattava di acquisire formalmente il certificato del carcere di Pianosa in cui si attestava che in quell’istituto di pena P.A. non aveva mai messo piede. Io, per prudenza, lo avevo allegato ai motivi e quindi, di fatto già stava agli atti e il P.G. non ne aveva chiesto l’esclusione per cui, anche se si fosse solo opposto, il documento rimaneva lì dove era.
Commentò, ridendo anche ad alta voce, Alberto Simeone, a cui avevo confidato la mia “mossa”: “che figlio di buona madre che sei, mi hai insegnato questo trucchetto, e bravo Giovannino”.
La Corte decise di rinviare l’udienza e si riservò di decidere sulle richieste.
All’udienza successiva, in apertura del dibattimento, il Presidente Antonio Rocco lesse l’ordinanza con la quale la Corte aveva accolto tutte le richieste di rinnovazione del dibattimento.
Era chiaro che il processo iniziava bene, la Corte voleva “controllare” i pentiti, voleva cioè, fare quello che di lì a qualche anno verrà imposto al giudice di fare, con una precisa norma del nuovo codice di procedura penale, voleva procedere al c.d. riscontro.
Finita l’udienza nella quale venne fatto un calendario fitto di date nelle quali si sarebbe svolto il processo di appello, rientrai a Salerno non prima di aver condiviso con Enzo Tortora e i suoi avvocati, la soddisfazione di quel primo risultato a nostro favore.

Dico a nostro perché, anche se io non avevo richiesto di sentire testimoni, quel provvedimento mi consentiva di argomentare le mie ragioni. Se era necessario riscontrare l’accusa dichiarativa del pentito, se era necessario “vestire” la prova del pentito come si diceva all’epoca, andava da sé che una sola prova “svestita” doveva portare all’assoluzione dell’imputato.
Rientrai a Salerno, perciò, soddisfatto e tranquillo.
Anche quella mia personale scaramanzia dell’onda e della risacca, sembrava andare nel verso giusto. La Corte di Assise di Milano aveva condannato all’ergastolo Michele Sindona quale mandante dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli, curatore fallimentare della Banca Privata Italiana, e quindi, ora, poteva starci, nella risacca l’assoluzione di Enzo Tortora e di P.A. al quadrato.
Mi potevo, perciò, mettere anche a vedere, in completo relax, i mondiali di calcio che si stavano svolgendo in Messico e, in particolare Maradona.
Io sono da sempre milanista e proprio quell’anno Berlusconi aveva acquistato la mia squadra con proclami di farla diventare di nuovo grandissima e degna della sua storia (promessa mantenuta); ma davanti a Maradona non c’è possibilità di resistere o di discriminare per la maglia che indossa.
Maradona è di tutti quelli a cui piace il calcio, dovrebbe, se fosse possibile, essere dichiarato patrimonio dell’Unesco. E proprio in Messico dimostrò la sua immensa grandezza: l’Argentina non vinse quel Mondiale, lo vinse Maradona!
Le varie udienze si succedevano con un ritmo serrato e in ognuna di esse si veniva dipanando la matassa delle calunnie costruite a tavolino dai pentiti e dai testimoni.
Dichiarerà 30 anni dopo il Giudice Morello “noi facemmo 100 nuovi accertamenti istruttori. Quindi è evidente che ci fu una carenza istruttoria in primo grado”.
Ricordo bene Italo Clerici, il direttore degli studi di Antenna 3, che nell’udienza
dell’8 luglio 1986 (due giorni dopo che a Londra Boris Beker si era riconfermato campione del torneo di Wimbledon questa volta con il mio tifo a favore perché l’avversario era l’odiosissimo Ivan Lendl) confermò di aver invitato Margutti come spettatore alla serata di beneficenza per l’Unicef, ma escluse che il pittore e la moglie avessero potuto muoversi per i corridoi e negli altri studi
della televisione. Quindi a maggior ragione escluse tutta la storia della rottura dell’elastico degli slip della moglie del pittore.

Pensai tra me che una cosa così semplice, era assurdo che non si fosse fatta in I grado così come, era assurdo che durante la fase istruttoria si fosse omesso di fare l’unica verifica logica sui numeri di telefono rinvenuti in una perquisizione con a fianco scritto “Enzo Tortora”, e cioè comporre il numero 442168 per sentirsi rispondere dal signor Enzo Tortona e fare poi il numero 325095 per
trovare la signorina Marta Antonia Onofrio, fidanzata di Giancarlo
Tortona, fratello di Enzo Tortona.
Oramai procedeva tutto per il verso giusto e la distrazione mentre guidavo non era più legata al pensiero del processo, ma ad altro.
Mi va di dirlo, ero passato dal “pensare” a D’Amico Pasquale a pensare a Kim Basinger e in particolare al suo culo nell’ultima scena dello spogliarello di 9 settimane e mezzo, film uscito in quel periodo che mi aveva “colpito” molto.
Un culo a forma di cuore che appare sotto lo scorrere di una sottana di seta che scivola con la giusta velocità. Il culo più bello del cinema di tutti i tempi!
Secondo me quel “pensiero” era un altro segnale di ottimismo, il culo nella cabala è la fortuna, il numero 16; e poi il culo è una parte del corpo sorridente, allegra, ovviamente quando è come quello di Kim Basinger o di Sharon Stone.
Durante queste udienze pure io contribuì ad arricchire il materiale probatorio che serviva per la decisione: P.A.2 mi aveva consegnato una lettera che aveva ricevuto dal Pentito D’Amico Pasquale in persona nella quale questi gli chiedeva scusa per averlo accusato ingiustamente. Con un tono di grande paternalismo, finto moralismo e senso della famiglia che può avere chi si è reso colpevole fra l’altro dell’assassinio, con successivo “impalamento”, di un detenuto nel carcere di Poggioreale appartenente ad un clan rivale, il pentito scriveva: “Compare, io a te non ti ho legalizzato e non so se fai parte della NCO l’unica cosa che voglio dirti è che ho un peso sulla coscienza e che da padre di 5 figli non posso più sopportare cioè che tu stai in prigione perché me lo avresti confidato a me ed altri pentiti a Pianosa(…)“.
Ovviamente il P.G. si oppose con tutte le sue forze e insisteva sul fatto che non si poteva acquisire il documento sia perché non lo avevo richiesto nei motivi di appello (ero secondo lui decaduto), sia perché non c’era la certezza che fosse firmato autenticamente da u’ cartunaro.
Io mi limitai a dire che il documento era successivo alla presentazione dei motivi e che per la firma si sarebbe potuta fare una perizia calligrafica.
La Corte acquisì la lettera con riserva di decidere sulla eventuale perizia.
Anche questa volta Alberto Simeone presente in aula al mio fianco, tirò in ballo mia madre con il solito appellativo quando seppe quale era il mio colpo segreto.
Dissi ad Alberto che ormai quella lettera era entrata nel fascicolo ed era di D’Amico perché l’autenticità della firma la si vedeva ad occhio nudo confrontandola con le decine di firme del pentito in calce ai verbali di interrogatorio che erano in atti. Il Giudice è o no peritum peritorum?
Fu a questo punto che Alberto con il solito sorriso e con la gioia per il collega e l’amico, evocò quella “buona donna” di mia madre.
Comunque terminate le udienze anche in questo grado di giudizio, iniziò la fase della discussione e dopo la requisitoria del P.G. che chiese l’integrale conferma della sentenza di I grado, il mio turno di intervento fu fissato, udite udite, il 31 luglio. E’ questa la data del “mio” processo Tortora, 31 luglio giorno in cui si festeggia San Ignazio di Loyola.
Questo santo è famoso per i suoi aforismi uno dei quali si abbinava bene al processo in corso: “Chi si trova nella desolazione si sforzi di conservare la pazienza, che si oppone alle sofferenze che patisce; e pensi che presto sarà consolato, se si impegna con ogni diligenza contro quella desolazione.”

E infatti bisognava avere pazienza e aspettare quel giorno con impegno diligente.
Si era verificata, con il 31 luglio la c.d. “ripetizione”; una combinazione che imparano bene, me compreso, i giocatori di roulette che lasciano la puntata sul numero vincente e ritirano solo la vincita, anzi, il vero giocatore (anche io), raddoppia la puntata e sulla originaria fiches ne aggiunge un’altra prelevandola da quelle vinte.
Questo della ripetizione, però, era un segnale che non sapevo decifrare bene.
Se lo ponevo in relazione alla mia performance andava benissimo, ero stato (modestamente) bravo; ma se lo ponevo in relazione al risultato andava malissimo (tutti condannati).
Comunque quello era il giorno e per quella data dovevo essere pronto con un impegno diligente, come diceva il Santo Ignazio.
Quella mattina, a casa, quando mi preparai per andare in Tribunale non c’era neanche mia figlia Mariella. Era in vacanza con la madre a Praiano in una casa che avevo preso in affitto per il mese di luglio; agosto, sempre e solo Torraca, anche quando, grazie ad Antonio Amato, mio amico di vecchia data, ho villeggiato a Saint Moritz dove ho conosciuto la meraviglia della montagna d’estate ad agosto.
Nel mentre mi recavo a Napoli quella mattina pensai che ero diventato “grande”, o per lo meno mi illudevo di esserlo diventato. Non ero il primo della mattina, posto in genere riservato ai pischelli, ma ero più o meno a metà degli interventi programmati per quel giorno.

A me piace molto scherzare con me stesso e su me stesso, da solo; mi piace di ridere di me stesso, e in quella occasione così fu: pensavo di essere “grande” ma ridevo tra me e me perché sapevo di non esserlo.
Del resto avevo solo 31 anni, 1 in più dell’anno prima.
Giunsi nei pressi della “Ticino” e decisi di sfidare la sorte: andai a prendere il caffè nel bar dell’altra volta, nonostante ci fosse stata la condanna di P.A. al quadrato. Del resto avevo preso le mie precauzioni scaramantiche: avevo un abito blu invece che quello color panna dell’anno prima.
Ero stato abbastanza ottimista nel pensare che i colleghi che mi precedevano avrebbero finito per l’orario del mio arrivo. Attesi più di tre ore prima che arrivasse il mio turno e in quel lasso di tempo iniziò a salire la pressione; ho rimpianto l’anno precedente dove, da primo, non dovetti attendere la fine di nessuna discussione. Il nervosismo mi faceva anche giudicare male le “arringhe” dei colleghi colpevoli solo di essere in turno prima di me, ma in realtà erano tutti all’altezza della situazione.
Comunque arrivò il mio turno dopo ancora un ultimo supplizio e cioè dopo che fu decisa, mentre ero pronto, una pausa.
Sembravo in una scena da film comico quando, dopo una lunghissima fila, il Fantozzi di turno arriva allo sportello e l’impiegato gli abbassa la serrandina sulle dita dicendo “chiuso”.
Accumulai altra tensione perché, tra l’altro, fu rispettata la regola che i 10 minuti di interruzione dichiarati, durano30/40 minuti reali.
Ad ogni buon conto, al rientro della Corte, il Presidente mi diede la parola e iniziai il mio intervento di 54 minuti (tempo ripreso dalla cassetta registrata).

Mi sciolsi bene e iniziai a muovere le critiche alla sentenza e a dire che la firma della lettera di D’Amico ricevuta da P.A.2 era originale. Mi avvicinai al Presidente e gli mostrai quella in calce alla lettera messa vicina a una in calce a un interrogatorio e il Presidente e gli altri due giudici a latere si sporsero, guardarono, controllarono e, all’unisono, annuirono.
Mostrai anche al P.G. i documenti in questione, ma lui non annuì.
Sentivo che la Corte era dalla mia parte, o meglio, era laica, neutrale, equidistante da accusa e difesa, non perseguiva lo scopo di verificare se quello che avevano detto i pentiti andava a confermare l’ipotesi dell’accusa, ma solo di cercare di capire dove era la verità e se si potesse o meno arrivare alla certezza della colpevolezza.
A questo punto dissi che la presenza dei due documenti determinava la classica situazione della insufficienza di prove che all’epoca era una terza strada tra l’assoluzione e la condanna. Non era ancora entrato in vigore il codice Vassalli e non era ancora stato inserito l’inserto “al di la di ogni ragionevole dubbio” nella norma che disciplina la condanna dell’imputato, ma la situazione era di assoluto dubbio.
“Un dubbio, sig.i della Corte che è ancora più evidente se andiamo ad esaminare le modalità di acquisizione delle dichiarazioni, i verbali dove leggiamo ADR ma non sappiamo quale domanda è stata formulata e tanto altro ancora”.

A questo punto mi misi a cercare la pagina della informativa dei carabinieri dove c’erano riassunte le risultanze delle accuse dei pentiti e dove gli imputati erano indicati in ordine alfabetico e in grassetto.
Mi serviva evidenziare alla Corte che con le prove di P.A.2 non scritto in grassetto in quell’atto, si era motivata la condanna di P.A. che lo precedeva in quel rapporto dei Carabinieri. Volevo dare il colpo a sorpresa e criticare la superficialità con cui il Tribunale aveva letto i documenti.
La ricerca, però, come spesso mi capita quando indosso la toga, si era complicata perché le maniche larghe di quell’indumento in genere fanno svolazzare i fogli predisposti per essere consultati. A questo punto nella mia difficoltà evidente, con la testa calata nel mare di fogli che avevo davanti ormai rigorosamente disordinati, sentii il dott. Michele Morello dirmi: “avvocato pagina 265 del verbale del ……. 1983”.
Alzai lo sguardo e vidi il volto sorridente e disteso del giudice con il foglio in mano che me lo porgeva.
Non lo andai a ritirare. Avevo vinto e lo avevo capito in quel momento!
Il giudice seguiva la mia discussione e conosceva gli atti meglio di me.
Aveva scoperto da sé l’errore della sentenza di I grado, e si trattava di P.A. non di Tortora o Califano, del sindaco o dell’avvocato.
Era bastato che accennassi il problema del grassetto e dell’errore perché lui individuasse immediatamente il foglio a cui mi riferivo. Lo sapeva già!
Da quel momento anche Morello oltre il Presidente che mi era piaciuto fin dall’inizio entrò prepotentemente nelle mie grazie. L’altro, il terzo, il giudice Carmine Ricci era ormai, nella sua signorilità di portamento, inutile da decifrare: ora, se fosse stato contrario, era in minoranza nella mia immaginazione e nella mia speranza.
Continuai riferendo gli spunti che avevo sentito e annotato nel Convegno Nazionale di Magistratura Democratica che si era tenuto nel ponte del 1 maggio di quell’anno a Rimini e a cui avevo partecipato di proposito. Ricordo ancora un intervento del giudice Giuseppe Di Lello Finuoli che mi piacque anche per l’efficace etichetta che collegò alla semplice accusa dei pentiti senza riscontri. La definì con un termine di Giovanni Falcone, del cui pool faceva parte, una “scorciatoia probatoria”.

“Perciò sig.ri giudici della Corte il pentito non può rappresentare il punto di conclusione della indagine, dell’istruttoria. Il pentito con le sue propalazioni rappresenta il punto di partenza della istruttoria. D’Amico ci dice questo, e allora andiamo a vedere se c’è qualche elemento, di qualsiasi tipo, che lo conferma. Qui, Sig.i della Corte non ci si è mossi in questo modo che è quello che indica Giovanni Falcone che è il giudice che ha fatto parlare Buscetta, ma dopo è andato a controllarlo nelle banche, sui luoghi, nei documenti; qui si è iniziato e finito con i pentiti, si è presa una scorciatoia, una scorciatoia probatoria. Questo impianto, perciò, non può reggere in uno stato di diritto nel quale si chiede al giudice di motivare la sentenza. Quella di primo grado non è una motivazione che in punto di fatto e di diritto giustifica la scelta che il giudice ha operato. In quella sentenza i Giudici hanno voluto dirci: lo dice D’Amico, lo dice Barra, lo riferisce Mario Incarnato e allora non può che essere vero. Non è così. Quella sentenza vuole persuaderci della bontà della decisione, ma vi renderete conto che persuasione e giustificazione sono due concetti profondamente diversi. Voi dovete giustificare razionalmente la vostra decisione. Non dovete persuaderci della bontà e della opportunità della vostra decisione, dovete spiegarci l’iter razionale seguito per giungere a essa ”.
Questa volta rientrai a Salerno senza riposare come l’anno prima, anzi ritornai allegro, soddisfatto, euforico. Anche se per scaramanzia sia ai parenti dei miei clienti che ai miei amici e parenti che mi chiedevano del “famoso processo di Napoli”, rispondevo che era difficile: “speriamo bene”.
E’ proprio vero la vita, il lavoro, è come il gioco. Io dormo bene quando perdo al casinò; dormo agitato quando vinco. Avevo dormito 42 ore di seguito l’anno prima, neanche 1 minuto questa volta. Allora persi questa volta ……..
Questa volta ero in aula il 15 di settembre (pure il numero era propizio), nella smorfia il 15 è “u’ guaglione”, il ragazzo, quel ragazzo, professionalmente parlando, che ero io in quel giorno, quel ragazzo che dopo quella sentenza diventerà “adulto”; diventerà “quello” che aveva fatto quel processo storico e aveva sentito con le sue orecchie, in prima fila il Presidente della V sezione della Corte d’ Appello di Napoli, Antonio Rocco , dire che “in nome del popolo italiano” P.A. veniva assolto per insufficienza di prove e Enzo Tortora per non aver commesso il fatto.
La Corte aveva fatto giustizia sia per Tortora che piangeva insieme all’avvocato Raffaele Della Valle e baciava l’avvocato Alberto Dall’Ora, sia per P.A. che dalla “gabbia” che avrebbe lasciato di lì a poco, entro la sera, per tornarsene a Nocera dalla madre e dai fratelli, si slanciava in un abbraccio dell’aria oltre le sbarre che predisponeva a quello che mi avrebbe fatto l’indomani quando lo trovai sotto casa alle 8,30 mentre uscivo per andare a lavorare.
Non salutai Enzo Tortora, sarebbe stato impossibile avvicinarsi, ma sono sicuro che anche lui avrebbe voluto stringere la mano di quel giovane avvocato con cui si era intrattenuto a parlare di arte, architettura, sport.
Dopo tutto avevamo passato quasi due anni insieme, nel cortile, nell’aula a distrarci.
Il “mio” processo Tortora non finì quel pomeriggio.
Continuò perfino con il nuovo codice Vassalli.
Ma quello non sarà più il “mio” processo Tortora, sarà solo il processo di P.A.
Giovanni Falci